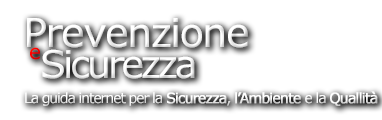News
"D.Lgs. 81/2008: il datore di lavoro e il principio di effettività"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
21/03/2013 - Per comprendere il principio di effettività va premesso, innanzitutto, che
è l’esercizio effettivo dell’impresa che consente di individuare la figura del datore di lavoro.
In applicazione di tale principio di effettività, infatti, l’articolo 299 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (“ Esercizio di fatto di poteri direttivi”),
inserito tra le disposizioni penali, ha esplicitato un principio da
decenni affermato dalla giurisprudenza, prevedendo che le posizioni di
garanzia relative a datore di lavoro, dirigente e preposto “gravano” in
modo peculiare “su colui il quale, pur sprovvisto di regolare
investitura,
eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”.
È interessante prendere in considerazione a tale proposito una
pronuncia della Cassazione emanata a seguito di un infortunio mortale
occorso ad un lavoratore in una cartiera a causa dell’organizzazione di
un sistema di lavoro errato e di un ambiente di lavoro fortemente a
rischio. A rischio “
sia per l’instabilità delle pesanti (ed
ingombranti) balle di carta accumulate l’una sull’altra senza essere
fissate al muro, in locali talvolta male illuminati ed inadeguati, sia
per il sistema di accatastamento e prelevamento delle stesse, che non
garantiva l’incolumità dei lavoratori”[Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 38428 del 22 novembre 2006].
La Corte d’Appello - in applicazione del principio di effettività (art. 299, D.Lgs. n. 81/2008) - aveva individuato il datore di lavoro nel “
soggetto che
concretamente impartiva disposizioni ai lavoratori ed organizzava l’attività aziendale, [il che]
consentiva
di indicarlo quale titolare della posizione di garanzia all’interno
dell’azienda e dunque di responsabile dell’incolumità dei lavoratori”.
Nel qualificare l’imputato come soggetto titolare della posizione
di garanzia all’interno della cartiera, la Cassazione ha confermato
l’impostazione della Corte d’Appello, affermando che, al di là della
qualificazione formale operata da quest’ultima (allorché aveva
identificato l’imputato come amministratore unico dell’azienda, di cui
era invece titolare ed amministratore la moglie), su quello incombeva
l’obbligo di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori in virtù
delle “
mansioni dirigenziali dallo stesso
in concreto ricoperte ed esercitate all’interno della stessa azienda, secondo quanto emerso dalle acquisizioni probatorie in atti”.
In particolare, l’imputato era stato indicato dalle dichiarazioni dei testi come “
il soggetto che dava le direttive ai dipendenti e che di fatto si comportava quale
effettivo titolare dell’azienda”.
Tale
approccio è coerente con l’orientamento ormai consolidato della Suprema Corte
secondo il quale “
in tema di infortuni
sul lavoro, l’individuazione dei soggetti destinatari della relativa normativa
[datore di lavoro, dirigente, preposto]
deve
essere operata
sulla base
dell’effettività e concretezza delle mansioni e dei ruoli svolti”
[Cass. Pen., Sez. IV, sent. n. 6025 del 20 aprile 1989] e “
deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita bensì sulle funzioni in
concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita al
soggetto (ossia alla sua funzione formale)” [Cass. Pen., Sez. Un., sent. n.
9874 del 14 ottobre 1992], come a dire che
la
mansione concretamente esercitata prevale sulla qualifica formale e apparente.
La
disposizione che individua come datore di lavoro non solo il
titolare del rapporto di lavoro ma anche, in alternativa o anche in modo
concorrente, il soggetto “
titolare dei
poteri decisionali e di spesa”, recepisce la lunghissima elaborazione
giurisprudenziale in materia, sviluppatasi a partire dal D.P.R. n. 547/1955
(ora abrogato), e trova applicazione in tutte quelle realtà aziendali complesse
nelle quali il titolare del rapporto di lavoro non è il soggetto che ha la
responsabilità concreta della gestione effettiva dell’azienda, o unità produttiva (o unità di
servizio per la pubblica amministrazione).
Può
dunque ben essere che in una medesima azienda, sotto un’unica ragione sociale,
vi siano, ai fini della prevenzione infortuni e malattie professionali, due
datori di lavoro responsabili di fronte alla legge quali principali soggetti
obbligati, principali debitori di sicurezza nei confronti dei lavoratori. Ciò
sempre però che questi soggetti dispongano dell’
adeguato potere direttivo, decisionale, gestionale e di spesa
necessario per garantire lo svolgimento sicuro dell’attività lavorativa
aziendale: queste condizioni devono risultare in modo netto e incontrovertibile
da documenti aziendali aventi data certa, che attribuiscano esplicitamente i
citati poteri e doveri.
Qualora
questi poteri incontrino dei limiti, è chiaro che detto soggetto risponderà
dell’adempimento dei propri doveri prevenzionistici esclusivamente nell’ambito
così delimitato, oltre al quale risponderà il soggetto a lui gerarchicamente
sovraordinato, nella linea gerarchica aziendale.
L’elevazione
del
criterio di effettività a
cardine
dell’intero sistema di
responsabilità prevenzionistiche (art. 299 D.Lgs. n. 81/2008) conduce al pieno
riconoscimento legislativo della legittimità di una
delega di funzioni, che resta (sia ben chiaro)
una facoltà, e non un obbligo, del delegante datore di lavoro,
avente efficacia pienamente liberatoria, secondo la visione della teoria
giuridica ‘funzionalistica’, e permette pure di risolvere l’annosa questione
dell’imputazione delle responsabilità infortunistiche all’interno delle persone
giuridiche.
In
relazione alle società di capitali l’amministrazione della società può essere
affidata ad un solo amministratore oppure ad un intero consiglio di
amministrazione; quest’ultimo può a sua volta trasferire le proprie
attribuzioni ad un comitato esecutivo o ad un suo membro, tramite l’ istituto della
delega
di cui all’art. 2381 codice civile.
Qualora
il consiglio di amministrazione abbia distinto le competenze e investito
espressamente il consigliere delegato dei compiti di amministratore
delegato o
presidente del consiglio di amministrazione, ad esempio, si realizza una
corretta individuazione del datore di lavoro di cui all’articolo 2 c. 1
lett. b) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81. Ma
resta fermo il potere-dovere di controllo generale a carico del
consiglio di
amministrazione sul concreto espletamento delle funzioni assegnate.
L’identificazione
del soggetto passivo dell’obbligazione di sicurezza quale datore di lavoro,
ovvero soggetto obbligato in via principale, può dirsi compiuta tenendo
presente la struttura effettiva dell’impresa e le mansioni esercitate
(principio di effettività): e quindi va a gravare su quel soggetto che è tenuto a compiere tutti gli atti
rientranti nell’oggetto sociale, compresi quelli volti ad assicurare che
l’opera dei lavoratori sia espletata nel rispetto delle norme sulla prevenzione
degli infortuni e di igiene del lavoro.
Deve
però precisarsi che la
posizione del
comitato esecutivo o dell’amministratore delegato, nei casi in cui
l’assemblea o l’atto costitutivo consentano la delega a questi delle
attribuzioni spettanti al consiglio di amministrazione, non può essere definita
a priori, a seguito della indeterminatezza della sfera di competenze dell’ organo delegato, che può vedersi
riconosciuti poteri di contenuto oscillante tra la mera esecuzione delle
decisioni consiliari (nel qual caso la qualità di datore d lavoro di cui
all’art. 2 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008 resta in carico all’intero
consiglio di amministrazione), da un lato, e al contrario la diretta titolarità
di proprie prerogative gestionali, dall’altro.
Più
in generale va detto che per individuare
i
garanti dell’obbligazione di sicurezza
non si può che appuntare l’attenzione sul contenuto delle competenze
concretamente conferite ai soggetti eventualmente delegati, ai quali la titolarità passiva
dell’obbligazione di sicurezza può essere dunque imputata nella misura in cui
ad essi spetti l’esercizio dei poteri di gestione necessari per conformare
l’organizzazione dell’impresa agli imperativi legali.
In
questo senso la Suprema Corte “
reputa che
si debba privilegiare la ‘
personalizzazione’
della responsabilità, riconoscendo la legittimità della delega e l’autonomia
dei poteri-doveri del delegato: all’applicazione della pena non può pervenirsi
in base a situazioni puramente formali, essendo fondamentale principio
costituzionale, quello secondo cui ognuno deve essere punito soltanto se abbia
coscientemente partecipato alla commissione dell’illecito” [Cass. Pen.,
sent. n. 5242 del 27 maggio 1996, Zanoni e altri].
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1300 volte.
Pubblicità