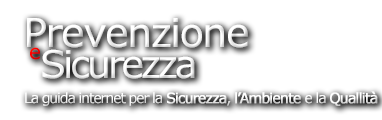News
"Dagli errori al miglioramento della sicurezza: il ruolo della comunicazione"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
03/05/2013 -
Pubblichiamo la relazione presentata al convegno "Comunicare il
rischio: strategie ed esperienze per fronteggiare i rischi negli
ambienti di lavoro" (Faenza 24 novembre 2012). L’intervento è a cura di
Antonio Zuliani (Psicologo psicoterapeuta, si occupa dell’applicazione
della psicologia alla sicurezza e all’emergenza da più di 20 anni).
Dagli errori al miglioramento della sicurezza: il ruolo della comunicazione
Al fine di comprendere in che misura gli errori possano condurre al
miglioramento della sicurezza sembra necessario partire da una breve
riflessione sul perché gli errori ci preoccupano in specie all’interno
del mondo del lavoro.
Sostanzialmente sono tre i grandi motivi che inducono questa preoccupazione:
-le conseguenze che possono determinare causando infortuni nei
lavoratori, danni a macchinari o attrezzature, lesioni a persone terze
con conseguente possibilità di incorrere nel pagamento di pesanti
risarcimenti;
-la costatazione che spesso al manifestarsi di un errore inizia una
sorta di “caccia al colpevole” che spesso si risolve
nell’individuazione di quest'ultimo piuttosto che nella comprensione del
perché è stato commesso un errore;
-la frustrazione che determina nella persona che scopre di aver
commesso un errore. Tutti faticano ad accettare di commettere errori,
anche se si è facilmente disposti a riconoscere negli altri questa
caratteristica.
Di fronte a tutto ciò la tentazione più grande è quella di
nascondere l'errore, un po' come si fa quando si cerca di “mimetizzare”
la polvere sotto il tappeto. Questa è una strategia assolutamente
inefficace rispetto quella che si cercherà di mettere in evidenza,
relativamente alla possibilità di comprendere l’errore all’interno di
un Sistema di Gestione della Sicurezza nell’idea che in questo modo l’errore può indurre un sostanziale miglioramento del livello di sicurezza sul lavoro.
Per affrontare il tema dell’errore umano si possono percorrere due
strade che, come vedremo, alla fine convergeranno. La prima vedere
l’errore dal punto di vista strettamente cognitivo, la seconda
attraverso connotati legati alle strategie che sia adattano di fronte ai
problemi.
Dal
punto di vista cognitivo occorre considerare che l’errore appartiene
all’esperienza umana perché il nostro cervello impara dagli errori. Il bambino quando
nasce non ha alcuna conoscenza e il suo apprendimento avviene attraverso la
sperimentazione delle cose che funzionano e degli errori; certamente
ci sono degli errori che permettono di imparare molto veloce (ad esempio il
fatto fuoco provoca delle dolorose scottature) e altri nei quali si continua ad
incorrere per tutto il corso della vita senza che arrivino a modificare i
comportamenti.
Gli
studi sugli errori percettivi evidenziano molti aspetti che vengono
sottovalutati nell’esperienza quotidiana e che, invece, hanno un’influenza
rilevante. Vediamone solo alcuni esempi:
-di
fronte a un problema, viene elaborata una prima valutazione sulla base dei dati
che ci appaiono salienti e che sono a portata di mano. Ciò determina una sorta
di “ancoraggio” percettivo che determina il modo in cui si andranno a
considerare tutti i dati successivi:
-di
fronte a due stimoli della stessa rilevanza si tende a seguire quello che
altera l’esperienza per primo, sospendendola verso l'altro;
-gli
stimoli inattesi intensificano la risposta delle aree cerebrali preposte alla
distribuzione dell'attenzione andando a coprire tutti gli altri;
-quando
una persona è impegnata in un compito che le chiede un alto livello di
concentrazione il suo cervello sopprimerà con maggior forza gli elementi che,
provenienti dall’ambiente, tendono a distrarla rispetto ai casi nei quali la
stessa persona è impegnata in un compito più semplice;
-la
memoria è costruita due volte: nel momento stesso in cui la si fissa, e ancora
nel momento in cui andiamo a recuperare i ricordi; in entrambi questi processi
ci sono dei vuoti che sono riempiti con inferenze inconsapevoli e solo quando
questi frammenti sono integrati e rendono sensata l’esperienza che si vuole
ricordare che ci ritroviamo di fronte a ciò che chiamiamo memoria.
Come
si può osservare la possibilità di incorrere in un errore è sempre presente e
appare del tutto illusorio pensare che ciò non avvenga con una certa frequenza.
Accanto
a questa lettura di carattere squisitamente cognitivo possiamo proporne una che
spazia anche su campi relativi alle modalità utilizzate per far fronte agli
eventi della vita.
Per
proporre questa chiave di lettura occorre ricordare che buona parte delle
decisioni vengono prese sulla base di due quadri di riferimento generali: i
frames e gli scripts cognitivi.
Frame
in inglese significa cornice, inquadratura e in psicologia indica una sequenza
di eventi tipo che la persona ha imparato e sulla quale si aspetta che le nuove
situazioni si sviluppino. In questo senso i frames condizionano la percezione
che la persona ha dell’evento rispetto a ciò che si aspetta possa accadere.
Possiamo dire che la consapevolezza che la persona sviluppa verso la situazione
che si trova a vivere è profondamente condizionata dai frames che utilizzerà.
Accanto
ai frames agiscono gli scripts che in ambito psicologico possono essere
identificati come i “copioni” che le persone utilizzano di fronte agli eventi.
Nel corso della vita le persone elaborano una serie di “copioni” che le aiutano
ad orientarsi quando incontrano eventi noti e che si ripetono. Ciò deriva
dall’esperienza, ma ancor di più da “significati” che permettono una visione
culturale condivisa degli eventi. Se i frames condizionano la percezione, gli
scripts hanno una grande influenza sulle reazioni delle persone di fronte
all’evento.
I
frames e gli script, pur appartenendo a un'esperienza passata, sono in grado di
determinare la nostra esperienza attuale. Quando queste attese sono violate il
cervello fatica e impiega comunque del tempo per elaborare in modo diverso i
dati percettivi, e questo può determinare sia errori sia ritardi nei processi
decisionali nelle situazioni critiche.
Quanto
detto mette in luce che appare molto difficile cercare di contrastare
attivamente la tendenza a commettere errori, ma al contempo ci si rende conto
che si possono elaborare le strategie di miglioramento incrementando i frames e
gli scripts a disposizione delle singole persone. Tale incremento permetterà
alla persona di reagire con maggior elasticità di fronte a un qualsiasi evento.
Di fatto la capacità di “intuire” ciò che avviene è legata alla disponibilità
di più frames da utilizzare potendo individuare quello più adatto a “inquadrare
efficacemente” quello che sta accadendo. Analogamente, una volta che sia stata
compresa la situazione è necessario avere a disposizione più strategie
(copioni) tra le quali scegliere la più adeguata a risolvere il problema che ci
si trova di fronte.
Ecco
allora che la strategia più efficace prevede un’attività formativa, di
confronto e di analisi degli eventi che aiuti le persone ad accettare che
l'errore esiste (non si dimentichi che le false sicurezze sono una grande fonte
di pericolo) e a elaborare una maggior quantità di frames e di scripts.
Da
questo punto di vista l’analisi degli errori diventa centrale sia che l’errore
sia visto come “evento sentinella” sia che venga intercettato prima del suo
manifestarsi.
L’evento
sentinella può essere definito come un fatto avverso di particolare gravità,
potenzialmente evitabile, che può comportare morte o grave danno alle persone o
alle cose.
Il
verificarsi di un solo caso è sufficiente per dare luogo a un’indagine
conoscitiva diretta ad accertare se vi abbiano contribuito fattori eliminabili
o riducibili e per attuare le adeguate misure correttive da parte
dell’organizzazione.
Si
tratta in altri termini di provvedere all’analisi puntuale di ciò che è
accaduto non andando alla ricerca di un “colpevole” ma di tutti gli aspetti
“attivi” (cioè strettamente legati all’evento incidentale) sia “latenti”
(risultanti da attività distanti, sia a livello spaziale sia temporale, dal
luogo dell’incidente, ma che possano averlo influenzato).
Se
nel primo caso andiamo ad occuparci prevalentemente delle dinamiche relative
alle azioni front-line rispetto all’evento incidentale, nel secondo si prendono
in considerazione anche gli aspetti legati alle attività di management, di
progettazione delle tecnologie, di produzione di norme e regolamenti.
Accanto
all’analisi degli “eventi sentinella” occorre segnalare l’importanza di
intercettare i “segnali deboli” che il sistema contiene rispetto a situazioni
che non hanno sortito ad un vero e proprio incidente, ma che possono
determinarlo. Si tratta di segnali che spesso il lavoratore vive nella sua
esperienza quotidiana e che è necessario sia aiutato a comunicare senza timore
di venir tacciato come un “rompiscatole” o come persone che “si preoccupa di un
non nulla”. Ad esempio se operatore segnala che due scatole di medicinali
possono essere confuse tra di loro a causa della confezione troppo simile invia
un messaggio molto importante ad un sistema che scelga di attivare una
procedura che eviti che, in situazione di stress, si possano confondere due
farmaci o due posologie tra di loro.
In
sostanza un buon Sistema di Gestione
della Sicurezza
deve includere la possibilità che ogni membro del sistema possa sentire che
l’azienda ricerca attivamente ogni informazione utile e ridurre gli errori, che
educa a riferire e che ogni nuova idea è la benvenuta all’interno di una logica
di responsabilità condivisa.
In
sintesi: dell’errore si può parlare e, liberato dalla preoccupazione del
giudizio e inserendolo all’interno di un sistema di gestione, esso genera un
processo di crescita e di miglioramento della sicurezza.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1260 volte.
Pubblicità