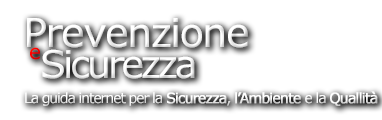News
"I processi inferenziali nella gestione dell’emergenza-urgenza"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
15/10/2013 -
I processi decisionali, organizzativi e di costruzione di senso –
sensemaking – consentono di attribuire un significato alla realtà osservata e
il loro sviluppo appare centrale per la diminuzione dell’errore clinico. Ecco
l’esempio di una lavoro condotto in questa direzione presso l’AUSL di Aosta.
I processi inferenziali nella gestione dell’emergenza-urgenza
Di Maurizio Catino, Massimo
Pesenti Campagnoni, Chiara Locatelli
1.Introduzione
L’articolo [1]
presenta i risultati di una ricerca condotta presso il pronto soccorso
dell’Ausl di Aosta [2] che
ha coinvolto gran parte dell’équipe medica ed infermieristica. L'osservazione
diretta delle pratiche lavorative ha consentito la ricostruzione dei processi
operativi e sistemici che caratterizzano questo particolare contesto
ospedaliero. Gli argomenti qui trattati si inseriscono all’interno di un
approccio di analisi organizzativa che analizza in modo integrato decisioni
mediche e organizzazione: i processi inferenziali tipici della professione
medica (le decisioni), con i processi lavorativi che caratterizzano il dipartimento
di emergenza (l’organizzazione).
In particolare, sono stati
indagati i processi decisionali, organizzativi e di costruzione di senso –
sensemaking – che consentono di attribuire un significato alla realtà
osservata. Parlare di creazione di senso significa considerare la realtà come
oggetto di una costruzione continua, che prende forma quando le persone danno
senso alle situazioni in cui si trovano e che hanno generato [3].
In questo caso si pone l’attenzione sulle strategie adottate dal personale
sanitario nella costruzione della diagnosi (valutando sia il contributo medico
che quello infermieristico), ovvero su quei ragionamenti inferenziali che
caratterizzano il processo di trattamento del paziente e di lettura dei weak
signs (i segnali deboli).
I processi di identificazione e
di valutazione dei sintomi sembrano seguire un modello simile alle detective
stories [4],
basate sul paradigma indiziario [5],
in cui le persone sviluppano la capacità di risalire da dati sperimentali a
prima vista trascurabili − indagandoli − a una realtà complessa che necessita
di essere riordinata e categorizzata (analizzare i dati disponibili per dare
significato alla patologia manifestata dal paziente).
La continua esposizione a eventi
inattesi, come l’arrivo di un paziente con un Codice Rosso o l’avere a che fare
con una patologia di difficile interpretazione, inducono i soggetti a elaborare
un processo di costruzione di senso proprio per strutturare l’incertezza e per
dare ordine a tutto quello che viene osservato. Tuttavia, diventa importante
categorizzare i processi inferenziali che si attivano, in termini di abduzione,
deduzione e induzione. Per abduzione si intende la formulazione di congetture
partendo da dati apparentemente insignificanti e non collegati tra loro, che
porta a ricostruire connessioni dotate di senso, come ad esempio la generazione
di ipotesi cliniche sulla base di sintomi e segnali apparentemente slegati gli
uni dagli altri, che non rientrano all’interno di uno schema concettuale
conosciuto o di cui si è già fatta esperienza. Per deduzione si intende
l’inferenza di un’ipotesi attraverso una serie di passaggi logici delle
conclusioni partendo da alcune assunzioni iniziali (dal generale al
particolare) come ad esempio i casi clinici che riportano sintomatologie visibilmente
evidenti in cui è possibile attivare processi di ragionamento capaci di dedurre
con certezza le cause. Infine, per induzione si intende l’individuazione di una
regolarità e la formulazione di una generalizzazione attraverso successive
prove empiriche (dal particolare al generale) come ad esempio le situazioni in
cui i sintomi riportati dal paziente possono essere riconducibili a più di una
patologia, mettendo il professionista nelle condizioni di aumentare il numero
di accertamenti per confermare una delle ipotesi formulate.
2. Operare nella medicina d’emergenza: il rapporto tra processi
decisionali e organizzativi.
Il pronto
soccorso (PS) è l’unità operativa dell’ospedale dedicata ai casi di
emergenza in cui sono necessarie cure immediate. È l’unità che deve assicurare
il primo accertamento diagnostico, clinico, strumentale e gli interventi
necessari alla stabilizzazione del paziente, nonché il collegamento con le
specialità di cui è dotato l’ospedale per gli interventi
diagnostico-terapeutici successivi.
Il pronto soccorso possiede
caratteristiche specifiche molto diverse dalle altre unità operative
dell’ospedale. Innanzitutto, mette in relazione la complessità della medicina
con le caratteristiche dell’emergenza all’interno di una struttura
organizzativa poco gerarchizzata. In tale ambito, le attività sanitarie non
sono programmabili in alcun modo, ma sono svolte sulla base delle richieste del
momento e rispettando le esigenze dell’urgenza (attività just-in-time).
Diversi studi [6] [7] [8]
evidenziano come la particolarità operativa del contesto dell’emergenza
sottoponga gli operatori a un elevato rischio di errore, in particolare nel
processo di costruzione della diagnosi. Diversi sono i fattori che
contribuiscono alla manifestazione degli errori nei dipartimenti di emergenza e
spesso dipendono dalle specificità organizzative che li differenziano dagli
altri reparti ospedalieri. Tali fattori possono essere sintetizzati come segue:
1) Generalmente gli operatori non
conoscono il paziente che andranno a visitare e le informazioni disponibili
sono insufficienti in termini di continuità e di completezza rispetto alla
storia clinica del paziente. Questo problema, inoltre, viene acutizzato dai
limiti di tempo e dalla necessità di accelerare le operazioni che richiedono
una certa urgenza.
2) L’elevato numero delle
decisioni e il carico cognitivo da sostenere (il background delle informazioni
a cui l’operatore deve fare riferimento). La combinazione tra la numerosità
delle decisioni e l’incertezza diagnostica può aumentare la probabilità di
commettere errori. L’alta intensità dei processi di decision-making [9],
tuttavia, diviene una delle principali caratteristiche distintive dei reparti
di pronto soccorso rispetto alle altre unità dell’ospedale.
Negli ambienti ad alta intensità
operativa e caratterizzati da condizioni di estrema incertezza, infatti, sono
numerosi i fattori che impattano sulle operazioni di decision-making. Per
quanto riguarda il caso specifico del pronto soccorso,
tutti questi elementi, tuttavia, influiscono in modo particolare sul processo
di costruzione della diagnosi e sull’attribuzione dei livelli di gravità delle
patologie (es. triage), aumentando i livelli di rischio e di difficoltà.
Durante lo svolgimento di un turno lavorativo, sono richieste numerose
decisioni cliniche che comportano un elevato onere cognitivo a causa della
scarsa disponibilità di risorse, di tempo e di informazione. Ogni singola
decisione presa, a sua volta, impatta su quella successiva determinando il
successo del percorso di trattamento clinico [10].
3) La difficoltà di preparare i
medici su tutti i casi clinici possibili. In accordo con gli studiosi [11]
di decision-making sono necessari circa 10 anni di esperienza di lavoro per
riuscire a garantire una pressoché completa conoscenza delle situazioni
cliniche prevedibili.
4) La carenza di feedback
ricevuti da altri specialisti, determinata dai limiti di tempo imposti dalla
necessità di intervenire con urgenza sul paziente.
5) L’impatto più forte esercitato
dai momenti di cambio-turno tra gli operatori. Il turnover può determinare
un’interruzione del trattamento del paziente e gli stessi turni
notturni possono abbassare i livelli prestazionali.
6) I limiti di tempo influiscono
anche sulle attività di metacognizione. I medici e gli infermieri che operano
nei dipartimenti di emergenza dispongono di tempi più ridotti per avviare
riflessioni sulla propria attività clinica e sul loro modo di valutare i casi
osservati durante la giornata lavorativa.
7) Gli elevati livelli di
incertezza e ambiguità. In situazioni di ambiguità le persone intraprendono il
processo di costruzione di senso perché sono confuse da una quantità eccessiva
di interpretazioni. In condizioni di incertezza, invece, le persone si trovano
a operare prevalentemente in assenza di dati e informazioni a cui fare
riferimento.
3. Il caso del pronto soccorso dell’Ausl di Aosta.
La ricerca, condotta nel pronto
soccorso dell’Ausl di Aosta, ha consentito di studiare le attività di lavoro
(decisioni e organizzazione) nelle situazioni di emergenza. In particolare
l’attenzione è stata posta sull’analisi di due aspetti:
1) il percorso di costruzione di
senso – sensemaking – tenendo conto della distinzione tra ambiguità e
incertezza;
2) i processi inferenziali
attivati durante l’elaborazione delle valutazioni di triage e delle diagnosi,
distinguendo tra abduzione, deduzione e induzione.
Lo studio, che si inserisce
all’interno di un ampio programma pluriennale di ricerca-formazione e
intervento definito dalla Direzione del Dipartimento d’Emergenza e dalla
Direzione Generale dell’Ausl di Aosta, ha coinvolto gran parte dell’équipe
medica ed infermieristica. Il contributo degli operatori è stato di
fondamentale importanza per la ricostruzione e per la comprensione dei processi
lavorativi che caratterizzano uno dei reparti ospedalieri con la più alta
intensità operativa e con i tempi di intervento più rapidi. In particolare, la
ricerca si è focalizzata sull’analisi del processo di sensemaking e sull’attivazione
di processi inferenziali (l’abduzione, la deduzione e l’induzione)
nell’attribuzione dei codici di gravità e nella costruzione della diagnosi
della patologia del paziente. Dal punto di vista metodologico, la ricerca ha
seguito un approccio basato sull’etnografia organizzativa: osservazioni sul
campo (diurne e notturne) per un totale di 90 ore, interviste (15) e colloqui
informali, focus group e analisi della documentazione interna.
4. L’analisi del processo di costruzione della diagnosi tra ambiguità e
incertezza.
Il termine sensemaking [12],
che letteralmente significa costruzione del senso si riferisce ai modi in cui
le persone generano quello che interpretano. Durante l’attività di sensemaking,
le persone creano il proprio mondo di riferimento e lo interpretano, pertanto,
il sensemaking include sia un processo di invenzione e un processo di
interpretazione [13].
Esso tende a manifestarsi in situazioni in cui l’ambiguità e l’incertezza sono
elevate. Il sensemaking organizzativo è una forma importante di processo di
costruzione di senso che emerge quando le persone utilizzano delle risorse per
interpretare e spiegare i fenomeni organizzativi. La realtà acquisisce il senso
che le viene attribuito dalle persone. In prima istanza, essa produce degli
stimoli che spingono gli stessi individui a insistere nel cercare di dare senso
a ciò che osservano.
Weick individua due esempi comuni
di sensemaking nelle organizzazioni:
1) l’ambiguità (mancanza di un
modello interpretativo);
2) l’incertezza (mancanza di
informazioni).
Si tratta di due situazioni del
tutto differenti.
1) In situazioni di ambiguità le
persone intraprendono il processo di costruzione di senso perché sono confuse
da una quantità eccessiva di interpretazioni. Vi è una mancanza di chiarezza o
di coerenza della realtà e le situazioni sono difficili da codificare in modo
preciso entro categorie esaustive ed esclusive. Quando le persone si trovano di
fronte a un evento ambiguo cercano di definire gradualmente il significato
attraverso la discussione, i procedimenti per prove ed errori e l’esplorazione
dei dati osservabili. Situazioni di questo genere si possono manifestare nel
momento in cui il paziente dichiara la presenza di una molteplicità di sintomi
che sembrano non aver alcun legame tra di loro e che potrebbero riferirsi a una
serie di patologie differenti. La situazione, può aggravarsi qualora la storia
clinica passata del malato sia caratterizzata da una molteplicità di eventi che
aumentano il livello di confusione.
2) In condizioni di incertezza,
le persone si trovano a operare prevalentemente in assenza di dati ed
informazioni a cui fare riferimento. L’incertezza si manifesta anche quando le
persone rilevano informazioni nuove, inusuali e inaspettate a cui si deve dare
un senso. In questo caso l’innesco del processo di costruzione di senso è
dovuto all’ignoranza, ovvero alla mancanza delle informazioni, che rende
imprecise le stime sulle conseguenze future di un’azione presente. La ricerca
dei dati, perciò, è focalizzata a colmare questa lacuna informativa e non a
rimuovere la confusione, che invece è generata dall’ambiguità. Un caso tipico
potrebbe essere la situazione in cui il paziente arriva in PS privo di sensi,
senza accompagnamento e senza disporre di documentazioni relative a patologie
passate. Il medico si trova nella totale incertezza e deve procedere alla
ricostruzione della diagnosi attraverso le informazioni che riesce a
raccogliere al momento.
La differenza che si origina
dalle situazioni dominate dall’incertezza e dall’ambiguità è la seguente:
- per rimuovere l’ignoranza è
richiesta più informazione, mentre
- per rimuovere la confusione è
necessario un tipo di informazione diverso che abbia degli elementi in più per
ottenere il senso del problema da affrontare.
5. I processi inferenziali.
Il processo di sensemaking si
inserisce all’interno di processi mentali più complessi volti a elaborare delle
inferenze dalla realtà circostante. Tali ragionamenti inferenziali si
distinguono in: abduzione, deduzione e induzione [14].
Vediamoli nel dettaglio [15] [16] [17].
1) La deduzione è il procedimento
razionale che fa derivare una certa conclusione da premesse più generiche,
dentro cui quella conclusione è implicita [18].
La deduzione è, quindi, quel processo logico per cui da un assunto iniziale,
attraverso una serie di passaggi logici necessari (inferenze), si derivano
determinate conclusioni. Il ragionamento deduttivo procede dal generale al
particolare. Questo metodo parte da postulati e princìpi primi e, attraverso
una serie di rigorose concatenazioni logiche, procede verso determinazioni più
particolari attinenti alla realtà tangibile. Nella deduzione la conclusione
scaturisce in modo automatico dalle premesse: date la regola e il caso, il
risultato non può essere diverso e rappresenta semplicemente l’esplicitazione di
ciò che era già implicito nelle premesse.
La deduzione, in quanto processo
logico, non fornisce nuovi elementi conoscitivi: il conseguente discende
automaticamente dall’antecedente. L’unico problema della deduzione è accertarsi
della correttezza dei passaggi logici: se questi sono corretti, e se
l’antecedente è vero, il conseguente sarà sicuramente vero.
2) L’induzione è un procedimento
che, partendo da singoli casi particolari, cerca di stabilire una legge
universale [19].
Esso consiste nello scoprire una regolarità e nel formulare una
generalizzazione attraverso successive prove empiriche, procedendo dal
particolare al generale. Questo processo di ragionamento logico consente di
ipotizzare una regola a partire da un caso e da un risultato: essa si basa sull’assunzione
che determinate regolarità osservate in un fenomeno continueranno a
manifestarsi nella stessa forma anche in futuro. L’induzione non è logicamente
valida senza conferme esterne e accresce il valore di verità di una
generalizzazione attraverso la ripetizione di un esperimento. Quanto maggiore è
il numero di esperimenti tanto più è affidabile il ragionamento.
3) L’abduzione, infine, consiste
nell’elaborazione di una congettura che, attraverso l’applicazione di una
regola, consente di spiegare il fatto indagato; in altre parole, indica una
conclusione ipotetica basata sull’osservazione di un caso particolare [20].
L’abduzione, da un lato, introduce un elemento di novità e, dall’altro, è
passibile di errore.
Il fatto osservato non è certo,
come nel caso della deduzione, né probabile, come nel caso dell’induzione, ma è
semplicemente plausibile. Da un lato, quindi, la possibilità di errore è
elevata ma è alta anche la possibilità di apprendere e di fare scoperte.
In sintesi, la deduzione prova
che qualcosa deve essere, l’induzione mostra che qualcosa è realmente
operativa, l’abduzione suggerisce che qualcosa può essere e che quindi
plausibilmente è. Nelle tre forme inferenziali si viene a creare una relazione
inversa tra la sicurezza delle conclusioni a cui si giunge e la ricchezza
innovativa dei tre processi logici. La deduzione presenta massima sicurezza, ma
non ci dice nulla di nuovo sulla realtà che non fosse già contenuto in quello
che viene definito antecedente. L’induzione è meno sicura in quanto, come
abbiamo visto, è sempre passibile di falsificazione attraverso un ulteriore
esperimento, ma ci dice qualcosa di più sulla realtà in quanto corrobora o
indebolisce l’antecedente. L’abduzione, infine, è altamente rischiosa, in
quanto ci obbliga a esplorare nuovi percorsi interpretativi e ci induce ad
avanzare nuove ipotesi, plausibili ma incerte.
La ricerca condotta nel pronto
soccorso ha messo in evidenza la complessità dei percorsi di ragionamento
adottati dal personale sanitario e la presenza combinata dei tre processi
inferenziali. Di particolare importanza per il presente studio è stato il
processo logico dell’abduzione, in cui si generano delle teorie provvisorie
confutabili o confermabili con l’esperienza (tra gli esempi rientra anche la
diagnosi medica). È fondamentale che le organizzazioni che affrontano
situazioni rischiose e che vivono in ambienti incerti sviluppino la capacità di
leggere e di decodificare segnali deboli e talvolta impercettibili in tempi
rapidi. Indizi che rivelano il pericolo di crisi incombenti, di probabili
incidenti e di processi degenerativi in atto. L’abduzione richiede, quindi,
flessibilità, creatività e capacità di innovazione cognitiva per risolvere
questioni difficilmente interpretabili secondo le mappe cognitive normalmente
utilizzate. Le osservazioni condotte sul campo hanno permesso di categorizzare
le diverse modalità di procedere da parte degli operatori nella valutazione
delle condizioni del paziente e nella costruzione della diagnosi. In
particolare, tale variabilità è legata al tipo di caso clinico osservato: la
maggioranza dei casi trattati negli ambulatori chirurgici e medici seguono un
iter prevalentemente abduttivo, mentre quelli gestiti dagli infermieri
nella fase di triage seguono un iter deduttivo. Per quanto riguarda i pazienti
con una piccola patologia traumatica, la maggioranza dei casi osservati
presenta sintomi da cui sono facilmente inferibili le conclusioni, ovvero dalla
particolarità della situazione si riesce a generalizzare il problema legato al
malessere del paziente. Di seguito, a titolo di esempio, si riporta una delle
situazioni osservate:
Una paziente di 78 anni si reca
in PS dopo aver colpito lo stinco su una superficie molto dura. Siccome la
paziente presenta problemi di tipo vascolare il colpo ricevuto le ha provocato
la comparsa di un’ulcera sanguinante infetta. Il medico chirurgo dopo aver
rilevato il problema procede alla medicazione, prescrive la terapia e consiglia
la visita in un ambulatorio vascolare.
Tuttavia, sono frequenti anche i casi
in cui i medici e i chirurghi attivano un processo di tipo induttivo, in cui
partendo da dei sintomi ricorrenti ipotizzano la presenza di una particolare
patologia (come vedremo questo è il caso frequente delle fratture articolari,
in cui grazie a determinati fattori è possibile supporre la presenza di un arto
rotto). Di seguito, un esempio:
Una bambina di 5 anni si reca in
PS accompagnata dai genitori a seguito di una caduta con il triciclo.
Dall’anamnesi si ipotizza la presenza di una frattura a un braccio, pertanto si
richiede l’esecuzione di una radiografia e una visita ortopedica (in
consulenza). In seguito agli accertamenti viene confermata la presenza di una
frattura, pertanto l’infermiere esegue una fasciatura semirigida per bloccare
il braccio e il chirurgo propone il ricovero nel reparto di ortopedia in cui
verrà eseguita l’operazione.
Per quanto riguarda i pazienti
trattabili in ambulatorio medico, le patologie manifestate dall’utenza sono
caratterizzate da un maggior grado di incertezza o ambiguità, in quanto i
sintomi sono meno chiari e difficilmente decifrabili. L’ambiguità delle
informazioni, o la loro carenza, sembra che induca il medico ad adottare un
ragionamento più complesso che rientra esattamente nella categoria
dell’abduzione (ad esempio il dolore toracico, il dolore addominale, emicrania,
ecc.). Anche in questo caso, si mostra un esempio emblematico:
La paziente è una signora di 87
anni che entra in pronto soccorso priva di conoscenza. I parenti testimoniano
di averla trovata nel bagno di casa sua priva di sensi e di averla vista
vomitare più volte. Il medico raccoglie tutte le informazioni reperibili dalla
testimonianza dei familiari e dalla storia clinica del paziente (precedenti
ricoveri, malattie e patologie riscontrate, etc.), e rileva che la signora era
stata ricoverata la settimana prima per problemi neurologici. In base alle
informazioni ottenute il medico individua una prima diagnosi ed esprime il
dubbio di trovarsi di fronte a un ictus ischemico piuttosto che emorragico. Per
giungere a una diagnosi più certa richiede l’esecuzione di una TAC e chiama il
reparto di radiologia per verificarne l’immediata disponibilità. Una volta
ricevuto il consenso dei tecnici di radiologia, il medico conduce la paziente
affinché possa essere sottoposta all’esame. Date le gravi condizioni della
signora il medico e l’infermiere di turno accompagnano la paziente nel reparto
di radiologia in cui verrà eseguita la TAC. L’esame radiologico individua la
presenza di una grave emorragia cerebrale, la peggiore delle due ipotesi
diagnosticate in precedenza. A causa della gravità e della chiarezza della
situazione si decide di non approfondire gli accertamenti e viene comunicato ai
parenti che la paziente non si sarebbe salvata.
Va sottolineato però che quanto
affermato sinora attiene prevalentemente a una condizione generale. Diffusi, ad
esempio, sono i casi in cui i chirurghi adottano un ragionamento deduttivo – a
variare è solo la frequenza di accadimento (tabella 1).
Infine, un’altra figura
professionale che ci permette di effettuare delle costatazioni in merito alle
particolarità del ragionamento inferenziale è l’infermiere di triage, il quale
è tenuto a fare una diagnosi all’interno di uno spazio di tempo molto limitato.
Egli agisce attraverso l’individuazione del sintomo principale e vediamo che
tende ad attivare un ragionamento deduttivo nell’assegnazione dei codici di
gravità “gialli” e “rossi”, nell’assegnazione del paziente all’ambulatorio
ortopedico, mentre tende ad attivare un processo abduttivo nell’assegnazione
del paziente agli ambulatori medici, in cui il sintomo principale spesso è meno
evidente.
6. Considerazioni conclusive.
La comprensione dei processi
inferenziali all’interno delle organizzazioni complesse costituisce una delle
questioni di maggiore rilievo per poter garantire sicurezza e affidabilità, in
particolare per quelle organizzazioni che vivono in ambienti ad alto rischio e
in condizioni di incertezza ed ambiguità [21].
Attraverso analisi di questo tipo è possibile osservare e comprendere il modo
in cui le persone che operano nei sistemi organizzativi affrontano i complessi
problemi quotidiani e le situazioni inattese, il modo in cui applicano il
paradigma indiziario [22]
per costruire il senso di ciò che affrontano, per rilevare con anticipo i weak
signs.
L’ambito dell’emergenza, grazie
alle sue peculiarità ha offerto numerosi elementi per la trattazione di temi
strettamente legati ai processi di costruzione di senso (sensemaking). Riuscire
a combinare la necessità di condurre pratiche urgenti con il rispetto di
elevati standard di affidabilità e sicurezza rappresenta la sfida principale a
cui il personale di un pronto soccorso deve far fronte. Medici e infermieri
sono costantemente costretti a eseguire prestazioni in tempi ridotti garantendo
il minor numero di errori e approssimazioni possibili, i quali potrebbero
essere fatali per la vita del paziente. A differenza di altri reparti
ospedalieri, in cui il processo di cura può svolgersi all’interno di spazi
temporali più lunghi e con una relativa tranquillità, il pronto soccorso deve
essere in grado di mettere a disposizione professionisti capaci di intervenire
con immediatezza in situazioni molto diverse tra loro.
L’importanza della consapevolezza dei processi inferenziali
Nella pratica tutte le persone,
specialmente quelle che operano all’interno di organizzazioni ad alto rischio
come il pronto soccorso, si trovano continuamente all’interno di flussi di
esperienza disordinati governati da incertezza o ambiguità. Sono proprio questi
due fattori che contribuisco in modo decisivo – anche se attraverso
caratteristiche diverse – all’attivazione del processo di costruzione di senso.
Dal lavoro di ricerca emerge che l’attività diagnostica costituisce un processo
continuo attraverso cui gli operatori danno senso alle informazioni e
all’ambiente che le circondano.
Si osserva che il percorso
seguito dai professionisti è simile al caso delle detective stories [23],
ovvero processi di investigazione in cui il problem solver (sensemaker) riveste
il ruolo di un detective che tratta le criticità rilevate come casi di delitto.
Egli procede con una dettagliata indagine dei sintomi manifestati dal paziente
cercando di attribuirne le cause e di individuare le possibili soluzioni di
trattamento. Nella maggior parte dei casi le situazioni sono caratterizzate da
condizioni di incertezza o di ambiguità, dove nel primo caso gli operatori
tentano di comprendere le condizioni del paziente senza essere in possesso di
informazioni importanti, mentre nel secondo caso agiscono in assenza di un
adeguato modello interpretativo caratterizzato da una molteplicità di dati
apparentemente contraddittori.
Il processo di sensemaking,
tuttavia, innesca lo sviluppo di percorsi di ragionamento inferenziali basati
su diverse strategie di trattamento dei dati raccolti per la costruzione della
diagnosi. A tal proposito, facciamo riferimento ai processi di abduzione,
deduzione e induzione. Dall’analisi emergono differenze significative tra le
due specialità mediche presenti nel pronto soccorso (medico internista e
chirurgo) e gli infermieri che operano nella fase di triage: mentre l’approccio
abduttivo è molto diffuso tra i medici e i chirurghi, il ragionamento deduttivo
risulta essere il percorso maggiormente adottato dagli infermieri di triage.
[1] Una
precedente e differente versione dell’articolo è apparsa su “Rivista Italiana
di Medicina Legale”, vol. 34, n. 2, 2012.
[2] CATINO
M., LOCATELLI C., La costruzione della diagnosi in Pronto Soccorso: sensemaking
e non technical skills, Rapporto di ricerca, Direzione del Dipartimento di
Emergenza e Assistenza dell'Ausl di Aosta.
[3] WEICK
K.E., Sensemaking in Organizations, Sage Publications, Thousand Oaks, CA, 1995.
[4] CZARNIAWSKA
B., Management she wrote. On parallels between detective novel and organization
theory, in Studies in Cultures, Organizations, Societies, 1999, vol. 5, n. 1,
pp. 13-42; PATRIOTTA G., Sensemaking on the Shop Floor: Narratives of Knowledge
in Organizations, in Journal of Management Studies, 2003, vol. 40, n. 2, pp.
349-375.
[5] GINZBURG
C., Spie. Radici di un paradigma indiziario, in Id., Miti emblemi spie.
Morfologia e Storia, Einaudi, Torino, 1992.
[6] CROSKERRY
P., SINCLAIR M.D., Emergency Medicine: A Practice Prone to Error?, in CJEM
JCMU, 2001, vol. 3, n. 4, pp. 271-6.
[7] VINEN
J., Incident Monitoring in Emergency Departments: An Australian Model, in Acad
Emerg Med, 2000, vol. 7, n. 1, pp. 1290-7.
[8] TINTINALLI
J.E., PEACOCK F.W., WRIGHT M.A., Emergency Medical Evaluation of Psychiatric
Patients, Ann Emerg Med, 1994, vol. 23, n. 1, pp. 859-62.
[9] CROSKERRY
P., The Theory and Practice of Clinical Decision-Making, in Can J Anesth, 2005,
vol. 52, n. 6, pp. R1-R8.
[10] WEARS
R.L., LEAPE L.L., Human Error in Emergency Medicine, in Ann Emerg Med, 1999,
vol. 34, n. 1, pp. 370-2.
[11]
KLEIN G., Sources of Power: How People Make Decisions, The MIT Press,
Cambridge, MA, 1998.
[12]
WEICK K.E., Making sense of the organization, Blackwell Publishers Inc Malden,
MA, 2001.
[13] WEICK
K.E., Sensemaking in Organizations, Sage Publications, Thousand Oaks, CA, 1995.
[14] Il
testo citato raccoglie gli scritti più importanti di Charles Sanders Peirce
(1839-1914), divenuto famoso come l'inventore, o reinventore, di tre parole
chiave: pragmatismo, semiotica, abduzione. Le formulazioni originarie del
concetto di abduzione, da parte di Peirce, risalgono al 1923 e 1935.
[15] PEIRCE
C.S., Opere, Bompiani, Milano, 2003.
[16] FANN
K.T., Peirce's Theory of Abduction, Martinus Nijhoff, The Hague, 1970.
[17]
PAAVOLA S., Peircean Abduction: Instinct, or Inference?, in MAGNANI L., NEIRSESSIAN
N.J., THARGARD P. (a cura di), Model-Based Reasoning in Scientific Discovery,
Kluwwer, New York, 2005.
[18]
L'introduzione del concetto di deduzione si deve ad Aristotele (384 a.C.-322
a.C.), il quale lo identificava sostanzialmente con il sillogismo. Il termine
significa letteralmente condurre da. Deriva dal latino de (traducibile con da,
preposizione indicante provenienza), e ducere (condurre).
[19] Dal
latino inductio, dal verbo induco, presente di in-ducere termine che significa
letteralmente portar dentro, ma anche chiamare a sé, trarre a sé.
[20] Dal
latino abducere, da ducere, condurre, tirare.
[21]
CATINO M., Miopia organizzativa, il Mulino, Bologna, 2009.
[22] GINZBURG
C., Spie. Radici di un paradigma indiziario, in ID., Miti emblemi spie.
Morfologia e Storia, Einaudi, Torino, 1992.
[23] PATRIOTTA
G., Sensemaking on the Shop Floor: Narratives of Knowledge in Organizations, in
Journal of Management Studies, 2003, vol. 40, n. 2, pp. 349-375.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1286 volte.
Pubblicità