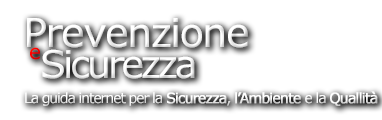News
"Il rischio microclimatico nei caseifici e nelle sale di mungitura"
fonte www.puntosicuro.it / Salute
17/10/2013 - Spesso quando si
affronta il tema della sicurezza sul lavoro si fa riferimento principalmente
alla prevenzione degli infortuni per i lavoratori, infortuni che nel mondo
agricolo sono legati spesso all’utilizzo di macchine e attrezzature. Ma la
tutela della sicurezza e salute ha in realtà a che fare anche con molti altri
aspetti, ad esempio il raggiungimento di determinate
condizioni di comfort e benessere termico.
Per parlare di benessere
termico, di microclima nel mondo agricolo, facciamo riferimento ad un
intervento ad una giornata di studio, dal titolo “
Salute e sicurezza sul lavoro nel comparto zootecnico e caseario”, organizzata
il 26 ottobre 2011 a Sassari dal Comitato consultivo dei Georgofili per la
prevenzione e la sicurezza sul lavoro agricolo, in collaborazione con l’ ASL Sassari e l’ Università di Sassari.
Ricordiamo che l' Accademia
dei Georgofili, fondata nel 1753 e con sede in Firenze, si propone di
contribuire al progresso delle scienze e delle loro applicazioni
all'agricoltura in senso lato, alla tutela dell'ambiente, del territorio
agricolo e allo sviluppo del mondo rurale.
Nell’intervento “
Il rischio da microclima nei caseifici e
nelle sale di mungitura” - a cura di
D. Monarca, R. Bedini, M. Cecchini, A. Colantoni, S. Di Giacinto, A.
Marucci, G. Menghini (Università degli Studi della Tuscia - Laboratorio Ergolab
- Dip. DAFNE – Viterbo) e P.R. Porceddu (Università degli Studi di Perugia –
Dip. Scienze Agrarie e Ambientali) – si indica che in molti ambienti di lavoro agricoli ed
agroindustriali “il benessere termico è difficilmente realizzabile, perché
l’uomo si trova spesso ad operare all’aperto o in presenza di animali, o in
condizioni di temperatura elevata (serre) o molto bassa (celle frigorifere) o
in situazioni in cui i parametri climatici devono essere tenuti all’interno di
determinati intervalli, per garantire produzioni conformi agli standards di
preparazione, di maturazione e di conservazione dei prodotti”.
L’intervento riporta diverse
indicazioni sulle caratteristiche del benessere termico, sui fattori che
influenzano il microclima e sottolinea che se ad oggi il microclima è un
rischio fisico per il quale il Decreto legislativo 81/2008 fornisce generiche
indicazioni di “adeguatezza” e “benessere”, si può colmare questa “carenza” con
il riferimento a
normative tecniche.
Queste “ultime propongono alcuni indici microclimatici di comfort e/o di
stress, indici che permettono di interpretare le condizioni
microclimatiche ambientali integrate con il tipo di attività svolta dagli
addetti”.
Nel documento relativo
all’intervento, che vi invitiamo a leggere integralmente, sono presenti diverse
tabelle contenenti, ad esempio, le principali norme tecniche in
relazione agli ambienti microclimatici e i principali strumenti di misura
utilizzabili ai fini della valutazione del rischio microclimatico.
Molto spazio è poi dedicato alle
metodologie di valutazione negli ambienti
severi, con particolare riferimento a:
- modello PHS, il “Predict Heat
Strain” (ISO 7933);
- indice WBGT: “la metodologia di
valutazione delle condizioni di lavoro negli ambienti severi caldi è descritta
dalla norma UNI EN 27243, che introduce l’indice WBGT (Wet Bulb Globe
Temperature)”;
- indice IREQ.
Le
industrie agro-alimentari sono “caratterizzate da particolari
lavorazioni che prevedono la presenza di notevoli escursioni termiche tra
luoghi diversi all’interno degli stabilimenti, anche in conseguenza della
specificità del ciclo produttivo”.
Si fa riferimento ad esempio ai
caseifici, alla produzione di formaggi.
In questo caso “le
fasi che possono presentare punti critici
per la salute dei lavoratori dal punto di vista microclimatico sono: la
maturazione tramite stagionatura in grotte o in forni; il mantenimento delle
caratteristiche organolettiche tramite l’immagazzinamento nelle celle
frigorifere; la lavorazione di formaggi
freschi e delle ricotte”. Gli addetti che operano all’interno delle aree di
stagionatura (grotte) sono soggetti ad una esposizione, oltre che alle basse
temperature, soprattutto ad un elevato tasso di umidità relativa.
Riguardo ai caseifici viene
presentato inoltre un
caso pratico,
con riferimento ad un indagine effettuata presso un caseificio del centro
Italia, con rilievi che hanno riguardato 7 ambienti differenti.
Gli autori si soffermano poi
sulle
aziende agrozootecniche e
sulle
sale di mungitura.
Infatti le strutture di
allevamento “sono caratterizzate dal mantenimento, anche forzato tramite
sistemi di ventilazione naturale e/o forzata, di un microclima favorevole agli
animali; questo a volte può provocare disagi per gli operatori (elevata
temperatura dell’aria ed elevato tasso di umidità causato dal vapore acqueo
prodotto dagli animali e dall’evaporazione dalle superfici bagnate)”.
Anche in questo caso è presentato
un caso pratico relativo a un’azienda sita nel comune di Viterbo che ha una
stalla per bovine da latte con 250 bovine in lattazione.
Veniamo brevemente alle
considerazioni conclusive
dell’intervento.
Innanzitutto le modalità di valutazione
del microclima negli ambienti di lavoro “costituiscono la base di partenza
per un intervento tecnico, volto a realizzare condizioni di comfort e di
benessere per gli addetti”. E tale intervento si articola in
quattro fasi:
- “
valutazione delle condizioni ambientali del luogo di lavoro e dei
parametri soggettivi dei lavoratori, che conduce all’individuazione del PMV (l’ indice PMV,
voto medio previsto, è utilizzato per la valutazione del comfort globale, ndr)
e quindi alla possibilità di definire il microclima come moderato, severo caldo
o severo freddo;
-
calcolo degli indici appropriati in funzione del punto precedente;
-
eventuale utilizzo di modelli di previsione delle caratteristiche
dell’ambiente di lavoro, in funzione dei risultati ottenuti da brevi periodi di
rilievo dei parametri ambientali;
-
proposta progettuale”.
Quest’ultima è finalizzata in
particolare alla “realizzazione di interventi di bonifica, attuabili nei confronti
dell’operatore e/o dell’intero ambiente di lavoro”. Ad esempio “è possibile
cambiare il vestiario indossato, modificando la sua resistenza termica, e/o il
dispendio metabolico, introducendo delle pause nei turni di lavoro o
realizzando una rotazione dei compiti. Si può invece intervenire sull’ambiente
di lavoro agendo su singole zone di questo o direttamente sulle sorgenti
termiche. L’esposizione al calore prevede l’utilizzo di indumenti leggeri, se
per una particolare lavorazione non è possibile soddisfare tale richiesta si
dovrà utilizzare un indumento speciale che non impedisca la sudorazione o che
abbia potere isolante adeguato”.
Uno degli aspetti sottolineati e
che meritano, a parere degli autori, un maggiore approfondimento “riguarda l’
acclimatazione dei lavoratori alle
temperature estreme e alla protezione dagli sbalzi di temperatura.
L’acclimatazione al caldo comporta una serie di adattamenti fisiologici e
psicologici durante le prime 2 settimane di esposizione. Cautele aggiuntive
dovrebbero essere adottate durante questo periodo e quando lavoratori in
cattiva forma fisica debbono essere esposti a condizioni di stress
termico”.
In relazione poi alle attività in
cella frigorifera “quanto più
elevata è la velocità dell’aria e quanto minore la temperatura nella zona di
lavoro, tanto maggiore deve essere il grado di isolamento degli indumenti
protettivi. Infatti la velocità dell’aria è una significativa concausa di
problemi di ipotermia, e pertanto va sempre mantenuta ai livelli più bassi
possibili. Una possibile soluzione tecnica di facile applicazione è quella di
collegare lo spegnimento dei ventilatori delle celle
frigorifere all’apertura delle porte per il passaggio dei muletti”.
Si ricorda inoltre che i lavoratori
più anziani o quelli con problemi circolatori “necessitano di protezioni
cautelative speciali contro il danno da freddo (es: l’uso di indumenti isolanti
aggiuntivi e/o la riduzione della durata del periodo di esposizione). Un fatto
è certo, ovvero che le azioni cautelative da prendere in esame dipendono dalle
condizioni fisiche dei lavoratori”.
La relazione si sofferma poi sul
“
pumping effect”: “generalmente,
l’abbigliamento è composto da più capi e, quindi, da più strati di tessuti
diversi tra i quali sono interposti strati di aria; quando le persone si
muovono quest’aria, insieme a quella che entra attraverso le aperture dei capi,
quali polsini e colletti, entra in movimento determinando un effetto, noto
appunto come ‘pumping effect’. Tale effetto può essere causato anche da elevati
valori di velocità dell’aria, dovuti ad esempio alla presenza di vento, che
possono provocare una compressione degli strati di tessuto, riducendone lo
spessore con conseguente variazione sia dell’isolamento termico che della
resistenza evaporativa”.
In definitiva le principali
indicazioni preventive riguardano:
- “l’introduzione di una
organizzazione del lavoro che limiti la durata di permanenza del lavoratore
negli ambienti troppo freddi (o troppo caldi);
- l’indossare un abbigliamento
idoneo a mantenere la giusta temperatura corporea e, in situazioni estreme,
utilizzare dispositivi di protezione individuale adeguati, prestando
particolare attenzione alla difesa di mani,
piedi e testa più sensibili al freddo;
- la limitazione del fenomeno
noto come ‘pumping effect’”.
“ Il rischio da microclima nei caseifici e nelle sale di
mungitura”, a cura di D. Monarca, R.
Bedini, M. Cecchini, A. Colantoni, S. Di Giacinto, A. Marucci, G. Menghini
(Università degli Studi della Tuscia - Laboratorio Ergolab - Dip. DAFNE –
Viterbo) e P.R. Porceddu (Università degli Studi di Perugia – Dip. Scienze
Agrarie e Ambientali), intervento alla giornata di studio “Salute e sicurezza
sul lavoro nel comparto zootecnico e caseario” (formato PDF, 523 kB).
RTM
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1376 volte.
Pubblicità