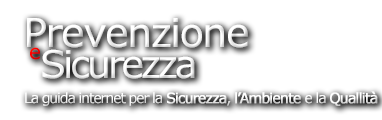News
"Design for all: come può contribuire alla gestione delle emergenze? "
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
05/12/2013 -
Ospitiamo un articolo tratto da PdE,
rivista di psicologia applicata all’emergenza, alla sicurezza e all’ambiente,
che si propone due importanti ed innovativi obiettivi nel panorama nazionale.
Da un lato presentare l’essenza del Design for All e dall’altro di declinarne
le potenzialità nel settore dell’emergenza.
Design for all: che cos’è e come
può contribuire alla gestione delle emergenze?
Di Pete Kercher
Ringrazio l’amico Antonio Zuliani
dell’opportunità di scrivere alcune righe per la rivista PdE, poche righe in
cui intendo solo abbozzare alcuni concetti, spunti se vogliamo, perché la
tematica di per sé meriterebbe un discorso (magari una discussione ospitata in
queste pagine?) ben più dettagliato.
Cominciamo allora dall’inizio,
con qualche definizione.
Non ci deve sorprendere se il non
addetto ai lavori è portato ad apostrofare il design senza tanti complimenti:
roba costosa, lussuosa, superflua e per pochi viziati. Lo vediamo sempre nelle
riviste patinate, no? Allora non fa per l’imprenditore che fa fatica a far tornare
i conti e tantomeno per il settore pubblico o per chi lavora con l’emergenza.
Ovvio.
Ma il design non è questa falsa
immagine:
il design è un processo
progettuale
che identifica una
sfida, analizza tutti le variabili in gioco (le tecnologie e le risorse
disponibili, per esempio, i destinatari e le loro esigenze e preferenze,
latenti oltre che conosciute)
e genera
risposte innovative e creative, possibilmente a basso costo e per venire
incontro alle esigenze di grandi numeri di persone. Oggigiorno affronta le
sfide non solo dell’ambiente tridimensionale e delle comunicazioni, ma risponde
ai quesiti anche dei servizi, dei sistemi e ultimamente anche delle strategie.
Il Design for All e il design
strategico spingono di più in questa direzione: secondo la Dichiarazione di
Stoccolma del 2004, redatta dall’associazione EIDD - Design for All Europe
sotto la mia presidenza, “
Design for All
è il design per la diversità umana, l’inclusione sociale e l’uguaglianza”.
In poche parole, questo ci dice che si tratta del processo progettuale (non del
prodotto) che mira a soddisfare la realtà della diversità umana (non la
finzione dell’”utente medio”), per consentire il raggiungimento
dell’uguaglianza (non la carità) in una società costruita sull’inclusione (non
su certi gruppi selezionati, quali le donne, gli anziani, gli immigrati, le
minoranze religiose or le persone con disabilità). Il DfA propone un
fondamentale cambio di paradigma nel modo in cui affrontiamo le sfide della
complessa società moderna.
Tutto quanto fa parte della
nostra esperienza - i luoghi, i prodotti, le comunicazioni, e servizi e i
sistemi - è stato progettato: a volte in modo coerente a consapevole, ma
spessissimo senza nemmeno rendersi conto che era in atto un processo progettuale.
Il risultato di questo “design
incosciente” - ma anche di una proporzione del tutto inaccettabile del “design
consapevole” - è la pletora di quanto si apostrofa fin troppo spesso con
l’etichetta di “errori progettuali”. Perché succede? Principalmente perché il
design classico, quello delle riviste patinate, si è basato su una falsa
concezione del mondo e dei suoi abitanti, che in pratica si riducono al comodo
modello di default dell’atleta olimpionico 25enne e maschile, in grado di
affrontare ogni ostacolo, gode di perfetta salute, ha tutte le sue facoltà
psicofisiche e nessuna delle regolari scomodità dell’essere donna.
Naturalmente è destro e
abbastanza benestante per poter volere e comprare tutti i feticci obbligatori
che si pubblicano nelle riviste patinate… Infine, per completare la su
perfezione, è immortale e non invecchia mai.
Questo, per ora, per quanto
riguarda il discorso relativo al design convenzionale (ambienti, architetture,
prodotti, comunicazioni, servizi e sistemi).
Quale può essere però la rilevanza di Design for All alle situazioni di emergenza?
Questo discorso si palesa in tre filoni principali: la prevenzione, la
prima risposta e il recupero post-emergenza. Rimanendo nelle mie intenzioni
di limitarmi qui ai soli accenni, abbozzerò risposte necessariamente
superficiali che però possono indirizzarsi verso evoluzioni più compiute.
Nel campo della prevenzione, un
buon progetto ha un ruolo di primaria importanza. Sebbene oggigiorno si possa
prevedere una parte sempre più ampia delle emergenze,
non si possono sempre prevenire del tutto. Eppure la correzione dei dissesti
idrogeologici conosciuti può contribuire in modo significativo alla
prevenzione. Cosa c’entrano il design e Design for All? Il principio del
coinvolgimento degli utenti del processo progettuale si può e si deve estendere
anche ai sistemi, tra cui il sistema del monitoraggio delle situazioni di
pericolo potenziale, che in larga parte sono conosciute da chi abita nelle
vicinanze ma che spesso non ha a disposizione un foro per far raccogliere le
proprie esperienze. Vanno progettati non solo gli interventi, macro e micro che
siano, ma anche il sistema logico che li gestisce nel medio e lungo termine.
Ricordare inoltre che la costruzione antisismica
è d’obbligo per la prevenzione è quasi superfluo, ma il modello va estesa agli
altri fenomeni di emergenza naturale che affliggono il territorio.
Subito dopo l’evento di
emergenza, qualunque sia, è d’obbligo per una risposta efficace un sistema
progettuale ben concepito in collaborazione con chi detiene la necessaria
esperienza (non per niente in lingua inglese si comincia a parlare non più di
“utenti” o “fruitori” ma di “experiencer”: portatori di esperienza). Qui non
intendo tanto le infrastrutture tangibili (seppure vada da se che sia
desiderabile una loro ottimale progettazione, naturalmente seguendo i dettami
del Design for All), ma il progetto dei sistemi di pronta risposta, che devono
funzionare senza soluzione di continuità, coprendo ogni eventualità con il
minimo di spesa.
Una chiara sfida progettuale che
deve comprendere come fattori integranti anche le caratteristiche che di solito
non si considerano come centrali alla prima risposta, come la defiscalizzazione
e la moratoria su pagamenti per privati e aziende, per evitare la seconda
morte, quella economica, di zone già martoriate. Questi fattori sono ancora
oggi trattati alla stregua non tanto di elementi concreti per il progetto di
risposta quanto di gentili concessioni da parte di governi centrali che a
volte, mi sia concesso di scrivere, sembrano non aver afferrato il concetto di
progettazione e programmazione.
Nell’intervento post-emergenza si
tratta di ricostruire non solo la fisicità dei luoghi colpiti, ma anche a
soprattutto il tessuto socioeconomico. In questo senso è ancora vitale il
coinvolgimento degli experiencer: l’intera comunità colpita ha qualcosa di
valore da contribuire e il compito del design strategico è fornire il foro in
cui questo possa avvenire. A che pro la ricostruzione (o la costruzione ex
novo) anche di interi quartieri dopo i terremoti,
se chi ci vive non ha più lavoro o senso di comunità? Anche situazioni di
questo genere chiedono con urgenza l’intervento del design.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1378 volte.
Pubblicità