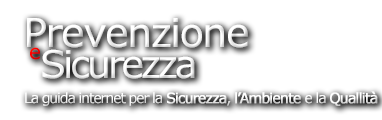News
"Le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e la valutazione di tutti i rischi"
fonte www.puntosicuro.it / Valutazione dei Rischi
25/01/2016 -
Ultimamente alcuni articoli di
Punto Sicuro hanno ospitato approfondimenti interessanti sulla valutazione di
alcuni rischi
specifici (p. es. il rischio chimico), che per loro natura risultano
piuttosto “difficili” da valutare.
Vorrei allargare un attimo il
campo partendo da questa legittima considerazione espressa qualche giorno fa da
Tiziano Menduto. Considerazione che, evidentemente, condivido.
Quello che mi interessa esprimere
e commentare, è la difficoltà di effettuare una valutazione di tutti i rischi
davvero completa là dove si prenda come “linea guida” la parte tecnica del
D.Lgs. 81/2008. Questo a fronte dell’obbligo che insiste sul Datore di Lavoro
di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
A questo proposito chi scrive, in
virtù dell’età “diversamente giovane”, ricorda bene l’effetto ingenerato dal
D.Lgs. 626/94 che introduceva chiaramente e inequivocabilmente il concetto di
valutazione dei rischi. Per rispondere
alla domanda degli “utenti”: “e ora esattamente cosa dobbiamo fare?”, molti
soggetti pensarono bene di predisporre delle liste di controllo in cui si
elencavano:
-
I possibili rischi, direttamente desunti dalle
disposizioni di legge vigenti all’epoca.
-
E le misure di sicurezza proposte dalle medesime
leggi per tali rischi.
Devo riconoscere che questo
approccio, che non mi è mai piaciuto sotto il profilo metodologico astratto, ha
consentito comunque a tanti di identificare i problemi presenti nell’ambiente
di lavoro e adottare misure di miglioramento utili a ridurre i rischi. Quindi
non possiamo che ringraziare chi, all’epoca, ha messo a disposizione tali
preziosi ausili.
Ma venti anni sono passati, e
forse sarebbe il momento di riesaminare i nostri approcci. E invece non lo
facciamo, perché consideriamo sempre la legge, ora il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,
come punto di partenza della valutazione. Quando c’è una modifica o una
integrazione alla legge ci poniamo quasi come se in quel momento “nascesse” un
nuovo rischio, o venisse modificato un rischio di cui evidentemente non eravamo
bene informati. Insomma, lo spirito della check
list è rimasto in testa a tanti che si occupano di sicurezza.
In difesa delle check list
Non voglio sembrare integralista,
quindi mi sento in dovere di chiarire che le check list (di pericoli, di
requisiti di sicurezza, di DPI …) sono uno strumento utilissimo per la gestione
in campo della sicurezza. Se io RSPP predispongo una check list per aiutare i
miei preposti a verificare periodicamente i dispositivi di sicurezza delle macchine,
non faccio forse qualcosa di estremamente utile?
Quindi le check list come
strumento di supporto per i “non specialisti” di una determinata materia sono
comunque qualcosa di assai utile. Ma non mi sembrano lo strumento più idoneo
per gli specialisti, specie se nell’utilizzarle ci si illude di avere una sorta
di garanzia di completezza.
La Valutazione di Tutti i Rischi
La questione che voglio porre,
prima di tutto a me stesso, è la seguente: come posso sentirmi sicuro di avere
valutato tutti i rischi che caratterizzano un determinato contesto lavorativo?
Qualche volta, dove il contesto
sotto il profilo della salute e della sicurezza è molto semplice (un ufficio,
per esempio), posso anche sentirmi ragionevolmente sicuro di avere osservato
tutto e di avere identificato tutti i pericoli e valutato i relativi rischi,
senza dover per questo fare ragionamenti o usare approcci complessi.
Ma se già passo ad un contesto
industriale … ebbene già in una azienda industriale di medie dimensioni non è
difficile dimenticare qualcosa. E se adotto l’approccio che io definisco a
check list, secondo il mio parere, è ancora più probabile che mi sfugga qualche
aspetto anche parecchio rilevante.
Quindi proporrei di “liberare la
mente” da tante sovrastrutture articolate (le check list, appunto, o se
preferite la volontà di perseguire il pieno rispetto dei requisiti di legge,
che a mio avviso è la stessa cosa), e ritornare alle fondamenta del risk based
thinking (bella definizione “inventata” nella nuova ISO
9001:2015). La domanda che ci dobbiamo porre è ovvia: “qui, in
questa azienda, ora o in futuro qualcuno potrebbe infortunarsi o contrarre una
malattia professionale?”. Se la risposta è sì, allora si avvia la valutazione;
ovviamente non cerchiano un mero SI/NO, cerchiamo piuttosto un elenco di sì,
ognuno accompagnato da e, non ultimo, da un quanto.
Ma se la domanda è astrattamente
quella più giusta, forse non è quella migliore sotto il profilo operativo.
Provo quindi a correggerla per renderla più facile da applicare: “qui, in
questa azienda, ci sono ora o ci saranno in un prevedibile futuro
pre-condizioni che potrebbero dare luogo a danni per le persone, siano essi
infortuni o malattie?”. Spostare il discorso dal danno alle pre-condizioni è
una semplificazione tecnica (che successivamente deve essere recuperata) che
libera il ragionamento da ogni elemento non indispensabile per il
riconoscimento
dei pericoli. Se è vero quello che sostengo in queste righe, che esiste una
concreta possibilità di non identificare pericoli e rischi che invece sono
presenti nel luogo di lavoro, allora semplificare la ricerca dei pericoli è, a
mio avviso, la strada da seguire.
Torniamo quindi a quelle che ho
voluto nominare pre-condizioni (che tutti ribattezzerete pericoli): intendo qui
quelle condizioni / situazioni / oggetti concreti che se sono presenti portano
un pericolo, se non sono presenti non portano nulla (ovviamente). In assenza di
pre-condizioni quindi non avrei né pericoli, né tanto meno rischi per la
sicurezza e per la salute delle persone. Vi chiedo, prima di imprecare, di
seguire il ragionamento ancora per un attimo.
In azienda ho una caldaia
alimentata a gas metano. Una caldaia di semplice riscaldamento, quindi nulla di
enorme. Il gas metano è una pre-condizione, o se preferite è una fonte di
pericolo. Può danneggiare la salute delle persone e/o può generare incendi o
esplosioni. Quindi ho un qualcosa di fisico (il gas) che introduce due
tipologie di pericolo. E qui arrivo ad una interessante biforcazione, ovvero
posso affrontare questa conoscenza (la presenza del gas) con l’intento di
capire i rischi concretamente introdotti, tramite due domande:
-
Quali sono le zone classificate secondo direttiva
ATEX e quali potrebbero quindi essere i relativi rischi di
esplosione?
-
Quali situazioni potrebbero comportare una
perdita di gas metano (che per definizione consideriamo potenzialmente
pericolosa)?
Sono due domande diverse, più di
quanto sembra. La prima richiede una analisi del circuito metano, la
identificazione delle conseguenti aree classificate (presso gli sfiati, le
valvole, le flange ecc.), il loro dimensionamento in funzione dei parametri di
impianto (pressione del gas, tipo della possibile perdita ecc.) e la verifica
che nelle aree classificate non ci siano fonti di innesco. E così (normalmente)
si finisce. Ovviamente se ci fossero punti di innesco in zona ATEX si
dovrebbero mettere in atto le misure di adeguamento / miglioramento necessarie,
ma poi davvero fine.
La seconda domanda può portare ad
utilizzare le tecniche di classificazione come supporto per identificare alcuni
scenari pericolosi, ma poi conduce a una analisi del contesto e degli scenari
che chi si occupa di classificazione ATEX delle aree è assai restio a fare. Per
esempio: se i tubi del metano corrono per un tratto all’esterno di un edificio
lungo cui transitano mezzi di trasporto, non è per caso possibile che un mezzo
di trasporto in caso di incidente colpisca e rompa i tubi, con conseguente
perdita?
È solo un piccolo esempio, altri
simili ne potremmo fare parlando di reazioni fra sostanze chimiche, di perdita
di vapore da valvole di sicurezza con sfiato in zone di passaggio … ne potremmo
fare davvero alcune decine che, per come siamo abituati a usare la legge e le
conseguenti check
list (come dicevo anche solo mentali), possono sfuggire molto
facilmente.
Cosa mi immagino (che possiamo fare)
Si, la via della legge come check
list è una via facile, soprattutto rassicurante. E poi pone argine a
una questione che ogni RSPP ha ben precisa davanti: “che mi direbbe il mio datore
di lavoro se per una mia negligenza subisse una prescrizione?”. Fare bene il
proprio lavoro evitando inutili prescrizioni (economicamente onerose) al datore
di lavoro (e indirettamente alla azienda). E non c’è nulla di sbagliato:
procedere in tal modo non comporta alcun male … diretto. Ovvero si opera sempre
a favore di maggiore sicurezza e salute.
Ma c’è un buco nelle nostre
fondazioni, il buco scavato da un tarlo, che è piccolo ora, ma che potrebbe
portare a un grave crollo. Così facendo (come sopra appena descritto) stiamo
privilegiando il rispetto della legge alla tutela delle persone! E se dovessimo
incappare in una di quelle situazioni (potenziali) che non abbiamo considerato
(per effetto della nostra check list), potrebbe accadere un disastro.
Volete un esempio? THYSSEN di
Torino. Tanti ragionamenti furono fatti dalla azienda (a quello che s’è detto
nel processo) sotto il profilo delle misure anti incendio obbligatorie, ma
qualcuno aveva anche solo pensato la dinamica dell’incidente che poi si è
verificato? Le misure anti incendio non messe in atto sarebbero state
sufficienti contro l’effetto “lanciafiamme” che si è verificato? Se non prendo
in considerazione la possibile dinamica pericolosa, partendo dalle
pre-condizioni e sviluppandole in scenario, posso anche essere a norma … ma lo
stesso estremamente pericoloso.
E qui arrivo al punto critico,
come spesso mi succede. Questo nostro mestiere non è banale, richiede tanta
capacità, volontà e attenzione, ha un valore etico e sociale indiscutibile ma
molto maggiore di quello che pensiamo giorno per giorno quando lavoriamo,
insomma è un mestiere difficile. Se ci togliamo il salvagente delle check
list siamo costretti a nuotare in mare aperto, e talvolta in un mare
in burrasca, senza neanche il minimo aiuto se non la nostra competenza tecnica
di base (che mai coprirà la molteplicità di argomenti diversissimi che dovrebbe
conoscere un RSPP).
Ma se la perfezione non è di
questo mondo, è anche vero che nessuno ci chiede di essere perfetti nei
dettagli. Dobbiamo invece concentrarti sui rischi, quelli veri, quelli che
hanno una potenzialità di danno tale da cambiare la vita del danneggiato. Il
resto sono quisquilie che alla peggio (se ci sfuggono) comportano esborsi
pecuniari, peraltro modesti.
È un cambio di mentalità, io lo
propugno da tanti anni ma ancora vedo poco, eppure non riesco ad immaginare un
approccio diverso che sia eticamente corretto. In fondo mi dico: noi esistiamo
e lavoriamo e siamo retribuiti per tutelare la salute e la sicurezza dei nostri
colleghi, prima di tutto! O sbaglio?
E se ho ragione: là dove non
vediamo un pericolo, siamo noi responsabili anche se poi, per la legge,
potrebbe essere punito un soggetto da noi diverso. Perché dove noi non vediamo,
possiamo stare (abbastanza) certi che nessun altro veda!
Alessandro Mazzeranghi
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1215 volte.
Pubblicità