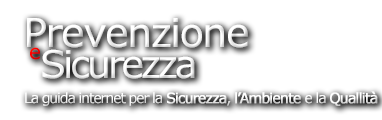News
"Ambienti confinati: sostanze pericolose e dispositivi di protezione"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
02/07/2012 - In relazione al pericolo per la sicurezza e salute dei lavoratori
nelle
attività in ambienti confinati
e ai numerosi gravissimi incidenti avvenuti in questi anni, torniamo a parlare
di fattori di rischio e di dispositivi di protezione idonei per ridurli.
E
lo facciamo con riferimento a quanto contenuto nel “ Manuale illustrato
per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi dell’art.
3 comma 3 del dpr 177/2011”, un manuale prodotto dalla Commissione consultiva
permanente che raccoglie le buone prassi richiamate nell’articolo 3 del Decreto
del Presidente della Repubblica n. 177 del 14 settembre 2011 – recante
norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in
ambienti sospetti di inquinamento o confinati.
Nel
documento le buone prassi sono presentate attraverso una
storia illustrata e dopo aver presentato – seguendo la narrazione –
adempimenti e prassi da mettere in atto prima di intervenire per la bonifica di
una cisterna, nella storia è il momento di approfondire la conoscenza dei
rischi, delle schede di sicurezza, dei DPI, di organizzare le procedure di
lavoro e operare le misurazioni stabilite.
Riguardo
al
rischio da sostanze pericolose o da
carenza di ossigeno, il manuale infatti sottolinea che
prima
di eseguire i lavori e durante il loro svolgimento, “è necessario verificare
che nella cisterna (o in altro ambiente confinato) ci sia una concentrazione di
ossigeno adatta alla respirazione (21/%) e non vi siano concentrazioni
pericolose di agenti chimici asfissianti, tossici o infiammabili. Il
monitoraggio dell’aria deve essere effettuato a diversi livelli di altezza per
tenere conto della differente stratificazione delle possibili sostanze
pericolose. Laddove possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera
vanno adottate specifiche cautele”.
Queste
sono alcune condizioni
di rischio che “possono esistere precedentemente all’inizio delle attività,
altre possono sopraggiungere durante l’esecuzione di alcuni lavori”:
-
“saldatura/taglio/brasatura;
-
uso di particolari sostanze (colle, solventi, vernici, prodotti per la pulizia,
ecc.);
-
uso di attrezzature di lavoro (ad es. che producono inneschi);
-
perdite da tubazioni presenti negli stessi ambienti o negli spazi limitrofi”.
Dopo
essersi soffermato sul
rischio di
asfissia, sul rischio di mancanza di ossigeno (a causa di scarso ricambio
di aria e o per inalazione/assorbimento di agenti chimici asfissianti tossici)
e sugli effetti di una concentrazione di ossigeno nell’aria ambiente inferiore
al 21%, il manuale riporta alcune
situazioni
di rischio associate a sostanze asfissianti:
-
“non adeguata rimozione di azoto (N2) o di altro agente a seguito di
attività di bonifica o inertizzazione;
-
fermentazione e decomposizione di sostanze organiche con produzione di anidride
carbonica (CO2), metano (CH4), idrogeno solforato (H2S)
se presenti composti solforati;
-
reazioni tra acqua del terreno, gesso e calcare, con produzione di anidride
carbonica;
-
processi di combustione;
-
reazioni di ossidazione all’interno di serbatoi di acciaio e recipienti
(formazione di ruggine);
-
reazioni tra rifiuti e ossigeno atmosferico;
-
reazioni di sostanze contenute all’interno di stive di navi, autobotti,
cisterne, e simili, con l’ossigeno;
-
dispersione di agenti estinguenti o refrigeranti come l’anidride carbonica,
azoto o agenti alogenati (halon, freon, argon) in ambienti non aerati;
-
ambienti o recipienti in aziende
vitivinicole;
-
reazioni di ossidazione da parte di alcuni tipi di materiali (residui,
incrostazioni, rifiuti, terreni)”.
Il
documento sottolinea che molti
gas
asfissianti “sono inodori, incolori e insapori, non sono rilevati dall’apparato
sensoriale umano e causano la perdita di conoscenza senza segni premonitori,
per cui l’uomo non riesce ad avvertire il pericolo in tempo”.
Questi
sono i
sintomi più facilmente
distinguibili:
-
“vertigini e progressiva perdita dell’equilibrio;
-
sensazione di pesantezza nella parte frontale della testa;
-
formicolio alla lingua ed alle estremità delle dita di mani e piedi;
-
difficoltà di parola, fino all’impossibilità di emettere suoni;
-
riduzione della capacita di effettuare sforzi fisici e di coordinare i
movimenti;
-
diminuzione della coscienza e di talune caratteristiche sensitive,
particolarmente il tatto”.
Ad
esempio il
rischio di intossicazione
si “può verificare in caso di:
-
impropria bonifica
di ambienti confinati con presenza di residui di materiali che possono
emettere gas, fumi o vapori ( per esempio H2S);
-
presenza di gas, fumi, vapori tossici che possono: invadere cisterne o serbatoi
tramite le condotte di collegamento;
essere prodotti durante attività di manutenzione;
-
presenza di sostanze liquide e solide che, in alcune condizioni, possano
improvvisamente rilasciare nell’ambiente gas o vapori pericolosi;
-
presenza di polveri;
-
presenza di liquidi e solidi che emettono gas tossici
in presenza di aria o vapori d’acqua (zolfo, fosfuri che emettono fosfina a
contatto di acidi ed acqua o vapore, ecc.);
-
reazioni chimiche di decomposizione o fermentazione;
-
ambienti sospetti di inquinamento o confinati dove si effettuano processi di
saldatura;
-
lavorazioni con solventi organici tossici o vapori tossici;
-
attività svolte nei pressi di fogne, bocche di accesso e pozzi di connessione
alla rete;
-
combustioni in difetto d’ossigeno;
-
scavi e fossi contenenti terreno contaminato, come scarichi di rifiuti;
-
reazioni tra sostanze incompatibili con accumulo di gas tossici (es. sostanze
acide con ipocloriti, solfuri, cianuri, ecc.)”.
Il
manuale ricorda che alcuni tipici esempi di sostanze tossiche sono: acido
solfidrico (H2S), acido cianidrico (HCN), solventi ed altri. E
sottolinea che nel caso dell’
acido
solfidrico o idrogeno solforato (H2S) il “caratteristico odore
di uova marce” a “concentrazioni uguali o superiori a 100 ppm, non viene più
percepito” (il nervo olfattorio si paralizza).
Dopo
aver parlato della concentrazione dei contaminanti, il documento si sofferma
sui
dispositivi di protezione
individuale e indica che il personale “deve disporre almeno del seguente
equipaggiamento:
-
maschere con filtro o respiratori isolanti;
-
elmetto per la protezione della testa da caduta di materiale dall’alto o
dall’urto con oggetti;
-
imbragatura di sicurezza;
-
protezione degli occhi se si è esposti a sostanze pericolose, proiezione di
schegge, ecc.,
-
indumenti di protezione”.
Secondo
quanto evidenziato dall’analisi dei rischi potranno essere necessari ulteriori
DPI, quali ad esempio i
dispositivi per
la protezione dalle cadute dall’alto (con riferimento a imbragature,
dispositivi di discesa, dispositivi di ancoraggio, sistemi
di arresto caduta, ...).
Per
stabilire qual è il dispositivo più idoneo per la
protezione delle vie respiratorie è necessario:
-
“identificare gli agenti chimici contaminanti eventualmente presenti, il loro
stato fisico (polveri, fibre, nebbie, fumi, vapori, gas) e la concentrazione;
-
stabilire la concentrazione di ossigeno (O2).
Ciò
è utile al fine di stabilire se utilizzare
DPI
respiratori dipendenti (a filtro) o indipendenti dall’atmosfera ambiente
(isolanti):
-
DPI a filtro, dipendenti
dall'atmosfera ambiente, quando il tasso di O2 è superiore al 19,5%
(facciali filtranti; semimaschere, maschere intere); possono essere usati al
posto degli autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la
concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, offrano garanzia di
sicurezza e sia assicurata un’ efficace e continua aerazione;
-
DPI isolanti (respiratori alimentati
ad aria o autorespiratori), indipendenti dall'atmosfera ambiente, nel caso che
il tasso di O2 risulti inferiore al 19,5%. Il principio di
funzionamento si basa sulla fornitura di aria respirabile prelevata da “zone
pulite” oppure da bombole o fonti esterne quali reti di aria compressa.
Proteggono sia da carenza d’ossigeno che da elevate concentrazioni di
contaminanti”.
Il
manuale sottolinea che
se l’ambiente è
sospetto di inquinamento “è necessario un monitoraggio in continuo della
qualità dell’aria”.
Per
un uso corretto dei DPI riportiamo infine le seguenti
indicazioni:
-
durata dei filtri: “vanno utilizzati
filtri di tipo e classi appropriati; poiché possono facilmente andare incontro
a saturazione e non fornire più la giusta protezione, vanno regolarmente
sostituiti per garantire le prestazioni di protezione, secondo le istruzioni
del fabbricante”;
-
addestramento: “i DPI
delle vie aeree sono di categoria III, per cui i lavoratori devono essere
addestrati all’uso corretto secondo le vigenti disposizioni in materia di
salute e sicurezza”;
-
pulizia e manutenzione: “ad
eccezione di quelli monouso, la manutenzione dei dispositivi deve essere
eseguita da persone competenti, secondo le istruzioni del fabbricante, e
prevedere ispezioni per l'individuazione dei difetti, eventuale sostituzione e
controllo delle prestazioni”.
Commissione
Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, “ Manuale
illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi
dell’art. 3 comma 3 del dpr 177/2011”, documento approvato nella seduta del
18 aprile 2012 (formato PDF, 3.33 MB).
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1152 volte.
Pubblicità