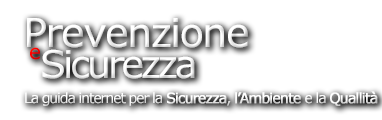News
"Laboratori: come prevenire l’esposizione alle radiazioni"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
01/09/2014 - Il termine “
radiazione” è usato spesso in modo
molto generico per descrivere fenomeni diversi tra loro che hanno in comune il
trasporto di energia nello spazio: ad esempio l'emissione di luce di una
lampadina, di calore di una fiamma o di particelle da una sorgente radioattiva.
Per fare luce sulle radiazioni,
con particolare riferimento ai rischi nelle attività di laboratorio, possiamo
riprendere la presentazione di un documento pubblicato dall’ Università degli Studi di Genova
dal titolo “ Linee
guida per la sicurezza nei laboratori”.
Un documento curato dal Dott.
Mauro Michetti che, malgrado abbia riferimenti normativi non ancora aggiornati
al D.Lgs. 81/2008, può esserci utile per comprendere il fenomeno delle
radiazioni e le possibili misure di prevenzione.
Quando si parla a livello
lavorativo delle radiazioni, spesso si fa riferimento all’esposizione a
radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.
In particolare l'azione lesiva
delle
particelle ionizzanti
sull'organismo “è una diretta conseguenza dei processi fisici di eccitazione e
ionizzazione degli atomi e delle molecole dei tessuti biologici dovuti agli
urti delle particelle quando hanno energia sufficiente per produrre questi
processi. A seconda che la ionizzazione del mezzo irradiato avvenga per via
diretta o indiretta si usa distinguere tra radiazioni direttamente ionizzanti e
radiazioni indirettamente ionizzanti”. I rischi connessi con l’uso delle radiazioni
ionizzanti “derivano dalla loro interazione con la materia. I meccanismi di
interazione sono diversi a seconda del tipo di radiazione, della sua energia e
delle caratteristiche del materiale attraversato, ne segue pertanto una diversa
capacità di penetrazione dei vari tipi di radiazioni nei vari materiali”.
Ad esempio si ricorda che le
particelle alfa, i raggi alfa, che “si
caratterizzano per la produzione di un’elevata densità di ionizzazione”, hanno
un basso potere di penetrazione.
Tuttavia si ricorda che i “materiali
isolanti come la plastiche, quando sono colpiti da radiazioni densamente
ionizzanti come le particelle alfa, diventano nel tempo fragili e polverulenti
(danno da radiazioni nei materiali). Questo problema è da tenere presente, ad
esempio, nelle sorgenti alfa emittenti da laboratorio, che devono essere
periodicamente sostituite, a causa del danneggiamento subito dal sottile strato
di plastica con il quale vengono sigillate”.
Il documento, che si sofferma
anche sul potere di penetrazione delle particelle beta, degli elettroni, delle
radiazioni X e gamma – indica che riguardo alle radiazioni ionizzanti
i “
provvedimenti da adottare per ridurre
l'esposizione e quindi le dosi ricevute sono piuttosto semplici e
consistono nello:
- schermare la sorgente;
- aumentare la distanza tra sorgente
e persona esposta;
- diminuire il tempo di
esposizione”.
Ad esse si devono poi aggiungere “appropriate
procedure di igiene del lavoro (uso di indumenti protettivi, barriere di
contenimento, ecc.) che rendano di fatto del tutto improbabile l'introduzione
della contaminazione nell'organismo umano”.
Si sottolinea, tuttavia, che
“nessuna esposizione alle radiazioni ionizzanti, per quanto modesta, si può
considerata completamente sicura”.
Si raccomanda pertanto un “
sistema di protezione radiologica basato
su tre fondamentali prìncipi:
- giustificazione della pratica;
- ottimizzazione della
protezione;
- limitazione delle dosi
individuali”.
Il documento segnala poi che le “
norme interne di radioprotezione” sono
“lo strumento per mezzo del quale vengono disciplinate le attività radiologiche
intorno a ciascun impianto o sorgente
di radiazioni. In esse vengono in particolare specificate le regole da
seguire per l'accesso e la permanenza nelle zone classificate ovvero per la
manipolazione e l'utilizzo delle sorgenti radioattive”.
Sono riportati due esempi di
norme interne, rispettivamente per un laboratorio dove si utilizzino isotopi in
forma non sigillata e per un laboratorio dove si usino apparecchiature a raggi
X (diffrattometri o cristallografi).
Queste sono alcune delle
norme di sicurezza per l'uso dei generatori
di raggi X, riportate dal documento:
- la zona controllata è contenuta
all'interno degli schermi;
- se gli schermi non vengono
rimossi, l'uso degli strumenti non comporta rischio di esposizione
apprezzabile;
- il montaggio dei campioni deve
avvenire con i raggi spenti o con le finestre chiuse. Dopo ogni modifica
controllare le tenute degli schermi;
- l'operatore deve assicurarsi
che la luce rossa sulla porta sia accesa prima di dare tensione agli apparecchi
ed ai tubi radiogeni;
- durante l'esecuzione delle
misure ogni pannello di protezione dell'apparecchio deve rimanere in posizione;
- durante l'esecuzione delle
misure è consentito l'accesso di visitatori nel locale solo con
l'autorizzazione dei responsabili.
Le linee guida si soffermano poi
sulle
modalità di decontaminazione.
Infatti nel caso di versamento di
materiale radioattivo “è necessario, in generale:
- limitare l’introduzione nel
corpo dei contaminanti radioattivi per inalazione, ingestione o contatto;
- limitare l’estendersi della
zona contaminata, circoscrivendola adeguatamente;
- rimuovere la contaminazione”.
A questo proposito sono
presentate indicazioni relative a:
- decontaminazione della persona;
- decontaminazione delle mani;
- decontaminazione di altre parti
del corpo;
- decontaminazione delle ferite;
- decontaminazione delle mucose
visibili;
- assorbimento digestivo;
- vie respiratorie;
- contaminazione dell'ambiente.
Il documento si sofferma poi
sull’estesa varietà delle radiazioni
non ionizzanti che riguardano gran parte delle spettro elettromagnetico. Ad
esempio: “campi elettrici e magnetici statici; radiazione elettromagnetica come
radiofrequenze (onde radio 300 Hz ÷300 MHz; microonde 300MHz ÷ 300 GHz);
radiazione ottica (infrarosso; ottica; ultravioletto; laser; ultrasuoni)”.
Riguardo ad esempio a
radiofrequenze e microonde si indica che i
livelli
di intensità di campo nelle zone di stazionamento degli operatori
“dipendono da: potenza del generatore, caratteristica degli elettrodi, grado di
schermatura, distanza dalla sorgente emettente in funzione della frequenza”. E
i
mezzi per ridurre l’intensità del
campo “variano in funzione della banda di frequenza, delle caratteristica
dell’apparecchiatura e della modalità di utilizzo. La riduzione del rischio è
possibile mediante: attenuazione dell’intensità dei campi, riduzione dei tempi
di esposizione, aumento della distanza delle postazioni di lavoro dalla
sorgente emittente in funzione della frequenza, eliminazione delle esposizioni
di persone non addette all’attività specifica”.
Nei laboratori le
misure di protezione possono essere
attive o passive:
- quelle
attive agiscono direttamente sul campo elettromagnetico in modo da
ridurlo entro i limiti di sicurezza (ad esempio con schermature e l’utilizzo di
dispositivi di protezione);
- quelle
passive riguardano il comportamento dell’operatore (si può limitare
l’accesso “alle zone interessate da campi intensi, riducendo il tempo di
esposizione e allontanando le postazioni di lavoro e i comandi dell’apparecchio
dalla zone di campo intenso”).
Ricordiamo che il documento, che
vi invitiamo a leggere, si sofferma anche su rischi e prevenzione nei
laboratori con riferimento specifico a campi magnetici statici, radiazioni UV,
ultrasuoni e sistemi laser.
Concludiamo l’articolo segnalando
infine che è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del
17 gennaio 2014 la Direttiva
2013/59/Euratom del 5 dicembre 2013 "
che stabilisce norme
fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti
dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive
89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom".
La direttiva - dovrà essere recepita dagli Stati Membri entro il 6 febbraio
2018 - si applica a qualsiasi
situazione di esposizione pianificata,
esistente o di emergenza che comporti un rischio di esposizione a radiazioni
ionizzanti che non può essere trascurato dal punto di vista della
radioprotezione in relazione all’ambiente, in vista della protezione della
salute umana nel lungo termine.
Università degli Studi di Genova,
“ Linee guida per la sicurezza nei laboratori”, a cura del
Dott. Mauro Michetti, Rev. Dicembre 2012 (formato PDF, 417 kB).
RTM
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1291 volte.
Pubblicità